Alle Sfilate Di ParigiL'Alta Moda(Non) Ha Perso Il Filo
- Massimo Porcelli
- 2 giorni fa
- Tempo di lettura: 4 min
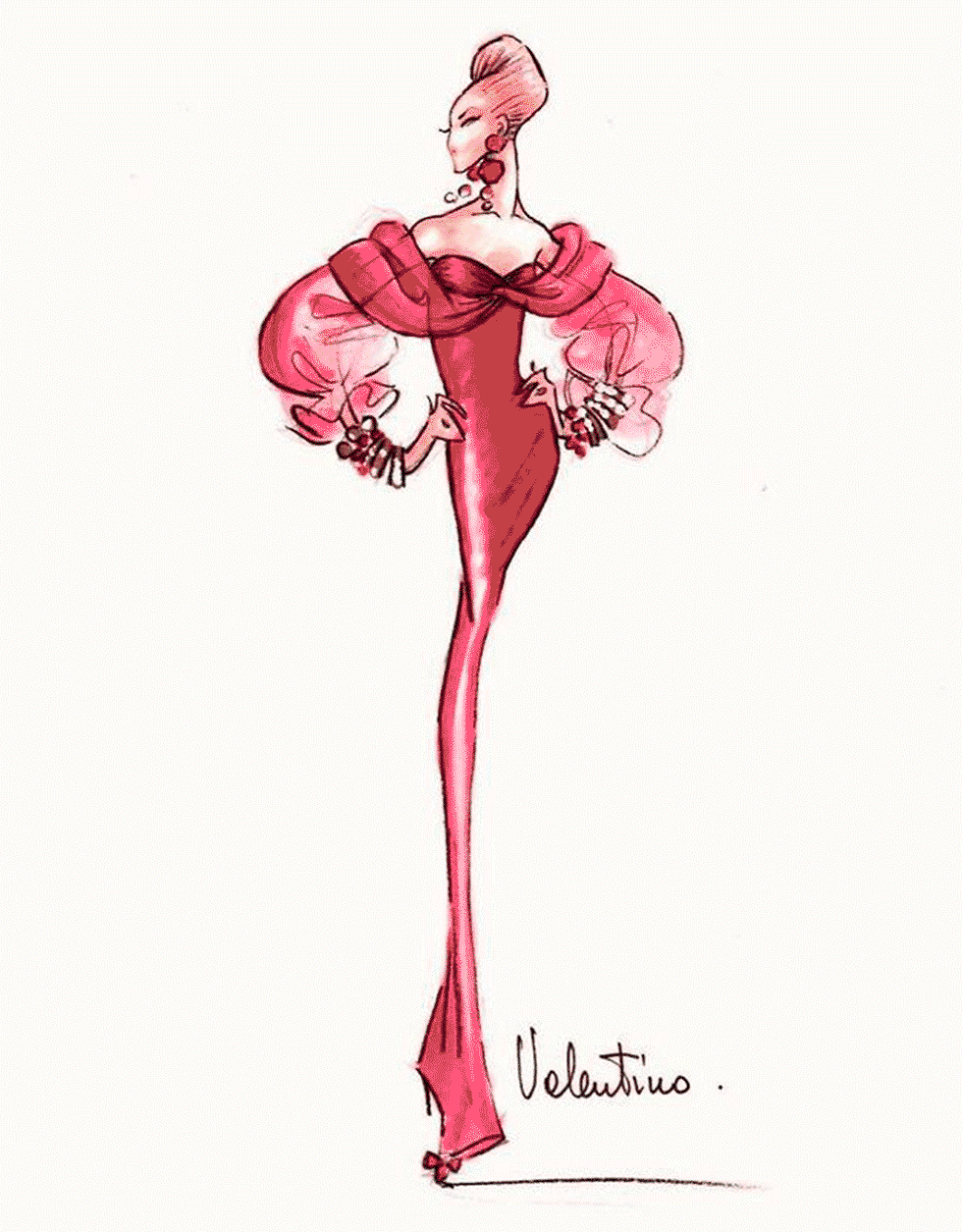
Meno clienti, più show mediatici: l'haute couture,
tra spettacolarizzazione e crisi d'identità, esiste ancora?
C’è stato un tempo in cui guardare le foto degli abiti di alta moda era uno dei nostri passatempi preferiti. Un rito elegante, quasi meditativo. Si correva in edicola, ci si sedeva comodi, si sfogliavano i numeri speciali di Vogue e Bazaar alla scoperta di abiti che non avremmo mai comprato ma che, in qualche modo, davano senso a tutto il resto. L’alta moda non era fatta per i comuni mortali, ma parlava anche a noi.
All’epoca — parliamo di anni Novanta, non del Settecento — la couture era un affare intimo, lento, rigoroso. Poche sfilate, pochi invitati selezionatissimi, pochi abiti, mostrati con calma. I defile duravano 45 minuti perché le modelle volteggiavano lente per far vedere ogni dettaglio, gli abiti erano non più di 30, tra giorno, pomeriggio, cocktail e grande soirée. L’abito da sposa era il gran finale e la segretezza era un must: le ricche e bizzose clienti non volevano farsi notare nè far sapere cosa cosa avessero acquistato.
Ovviamente nessun front row con star a cachet, nessun influencer, nessun bisogno di “fare il giro dei social”. La couture serviva a una cosa molto semplice e molto concreta: vendere abiti straordinariamente ben fatti a signore che avevano bisogno di un guardaroba esclusivo, impeccabile e, soprattutto, fatto su misura.
Oggi, invece, clicchiamo su play e guardiamo uno show che dura 15 minuti al massimo, costa milioni e verrà replicato in un numero incalcolabile di contenuti. Tutto questo mentre il mondo va a rotoli (guerre, clima, crisi economiche, intelligenza artificiale che ci ruberà il lavoro) e noi lì, che ci chiediamo se sia etico, sensato, persino decente dedicare il nostro tempo a abiti ricamati a mano, piume di struzzo, cristalli Swarovski, volumi che sfidano le leggi della fisica. La risposta istintiva è: probabilmente dovremmo occuparci di cose più serie, o no?
Tanto più che la moda — dalla haute couture al fast fashion — se la passa proprio male. E l'alta moda, da specchio amplificante del sistema, racconta benissimo questa crisi. Quindi guardare le sfilate serve ancora, ma per motivi completamente diversi da quelli di un tempo.
Ed è proprio qui che entra in gioco Dana Thomas - star indiscussa del giornalismo di moda - con la sua solita lucidità poco consolatoria. Nella sua ultima newsletter “The Style Files”riporta dati che fanno riflettere: il 70% dei fortunati spendaccioni del lusso ha cambiato brand negli ultimi cinque anni; il 50% percepisce il lusso come troppo orientato al profitto; il 36% dei VIC (Very Important Clients) rimprovera ai brand di lusso di essere diventati troppo accessibili e mainstream, riducendo la loro esclusività (noblesse oblige).
E poi: Il comparto Alta Moda aveva, nel 2022, circa 400 milioni di acquirenti attivi che nel 2025 (il 5% della popolazionee mondiale) si sono ridotti a circa 340 milioni, con una perdita netta di circa 60 milioni di consumatori in poco più di 2 anni. Un duro colpo se considerate che ogni cliente spende in media 500 mila euro l'anno mentre solo l'1% arriva fino a 5 milioni.
D’altra parte, se guardate il calendario dell’Alta Moda parigina andata in scena la scorsa settimana, troverete solo Chanel, Dior, Schiaparelli, Valentino, Saab e Armani tra i brand più conosciuti. Gli altri sono quasi tutti creatori di ultra nicchia che producono per una clientela ristrettissima e per nulla occidentale. Balanciaga stavolta ha dato forfait e nomi come Saìnt Laurent, Balmain, Givenchy se ne stanno alla larga. E allora ecco alcuni casi emblematici che ci aiutano a capire lo stato dell'opera.
Chanel: la Couture fatta per essere venduta
E'probabilmente l’unica maison che continua a fare alta moda nel senso più classico del termine: abiti raffinati, portabili, incredibilmente ben costruiti. È couture che si potrebbe davvero indossare, almeno in teoria. Il problema? I clienti sono sempre meno: un club ristrettissimo, silenzioso, quasi invisibile. Lo sa bene Matthieu Blazy, il nuovo direttore creativo che, da una parte, ha l’ingrato compito di ringiovanire il brand e dall’altro è guardato con sospetto dalle clienti più blasonate che amano la riconoscibilità e detestano le novità.
Dior: l’Alta Moda diventa comunicazione
All’estremo opposto troviamo Jonathan W. Anderson da Dior. Qui l’alta moda diventa uno strumento potentissimo di comunicazione: abiti spettacolari, pezzi da museo, immagini pensate per circolare ovunque. L’obiettivo non è tanto vendere moda, quanto ciò che fa da contorno: rossetti, profumi, borse, accessori. La couture diventa un gigantesco billboard pubblicitario che funziona benissimo: non ripaga in termini di fatturato ma fa un gran bene all'immagine. Sarà per questo che, mentre guardiamo la sfilata, sappiamo già che stiamo assistendo a una messa in scena pensata più per i media che per i guardaroba.
Schiaparelli e Valentino: l’Alta moda che sogna
Poi ci sono i casi più affascinanti e più complessi: Daniel Roseberry da Schiaparelli e Alessandro Michele da Valentino. Qui la creatività è esplosiva, colta, visionaria. Abiti magnifici, spesso mozzafiato. In passerella funzionano alla perfezione. In fotografia sono irresistibili. Ma nella vita reale? Difficili, teatrali, a volte quasi impraticabili. Più che vestiti, manifesti estetici. La couture come esercizio artistico, non come proposta da indossare.
Detto questo, sfilata dopo sfilata, sembra proprio che la couture non sappia più bene dove stia andando e a chi stia parlando. Ai clienti? Ai social? Agli investitori? E noi, davanti allo schermo del nostro computer, finita la diretta, ci sentiamo un po’ complici, un po’ spettatori stanchi. Continuiamo a guardare, ma senza quell’entusiasmo ingenuo di un tempo.
Forse la vera domanda non è se abbia senso guardarla, studiarla, parlarne. La domanda è: perché l’alta moda ancora esiste… e resiste?
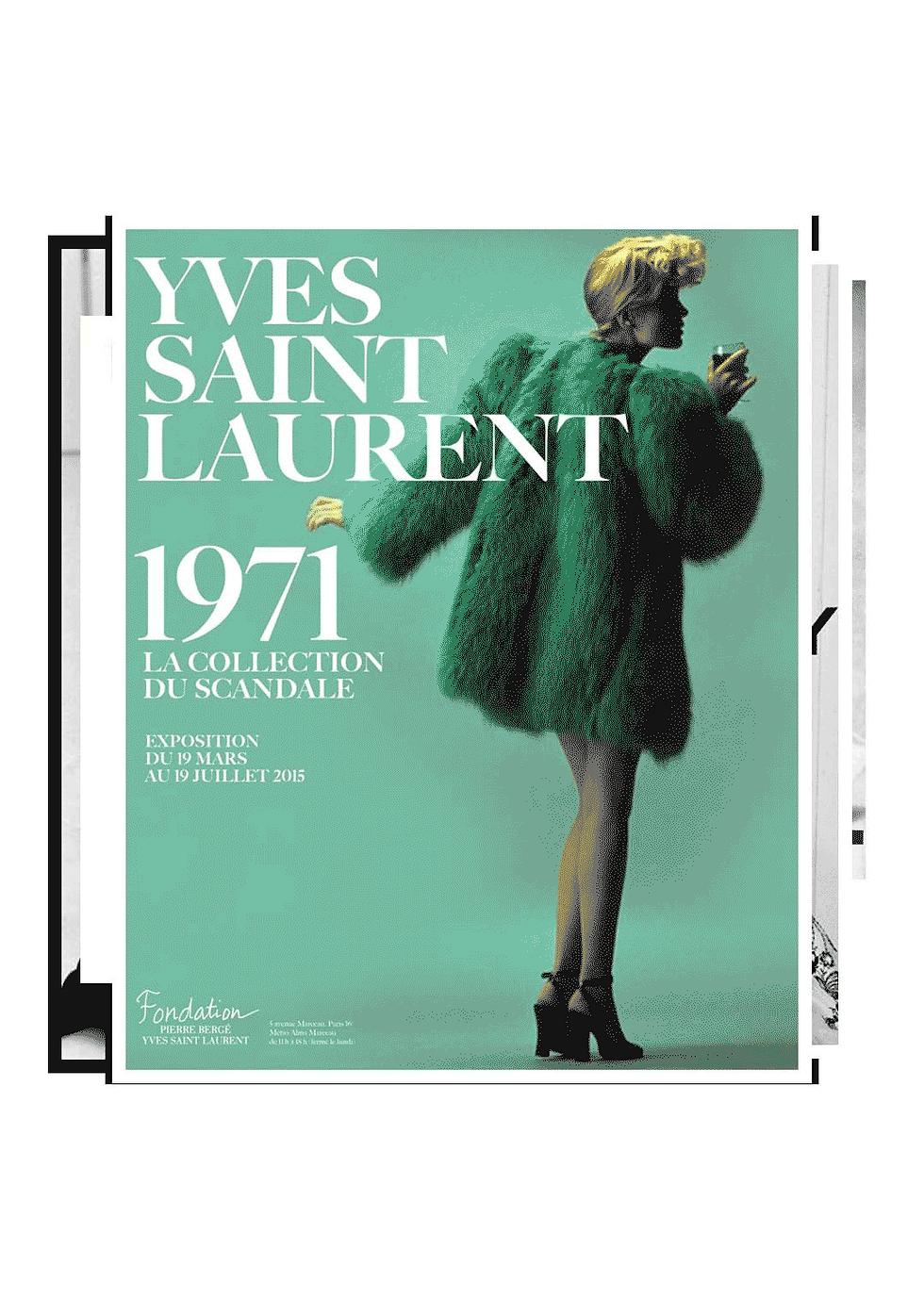


Commenti